venerdì, settembre 29, 2006
Balocchi, banchi e profumi
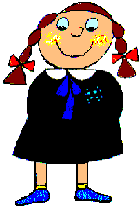
Della scuola ricordo gli odori. Quello chimico della stampa dei libri nuovi, quello resinoso di legno scheggiato delle matite appuntite, l’odore ingannatore delle gomme alla fragola e quello dolciastro delle penne colorate. Il profumo dei pioppi che ombreggiavano in cortile serviva a mitigare quella puzza fetente che si creava nell’aula dopo la seconda ora di lezione. Per non parlare della zaffata che sprigionavano le scarpe da ginnastica negli spogliatoi della palestra. L’acqua del rubinetto dei bagni sapeva di chiodi di garofano e le bidelle si trascinavano appresso un olezzo di alcool e Vetril che ti permetteva di conoscere in ogni momento la loro esatta collocazione nell’edificio. Nell’armadietto il vinavil imperava su tutte le altre fragranze. Le forbici con le punte arrotondate facevano pensare al sapore “plasticoso” dei giocattoli Mattel e la cattedra appestava l'aria di polvere di gesso. Nei giorni di burrasca entrava prepotente l’olezzo del mare e in quelli che seguivano il tanfo di vongole seccate al sole. La mia cartella rossa sapeva di pane e mortadella e la ricreazione scatenava l’aroma dei mandarini e delle merendine al cioccolato. La mia maestra stendeva sulle mani una crema densa che ricordava le caramelle mou e il suo alito profumava di caffè del distributore automatico. I maglioni di Simona sapevano di camino, quelli di Paola di lacca per capelli. Nadia odorava di latte e a dieci anni portava già il reggiseno. Alcuni maschi sapevano di pineta e altri di terra bagnata. La mia prima passione se ne stava seduto all’ultimo banco, pallido e occhialuto e, lo ricorderò sempre, emanava un delizioso aroma di noci tostate e di grano. Mentre io schiacciavo il naso contro la pelle liscia del mio braccio e lo leccavo per risentire il sapore dell’estate finita.
Ho continuato a guardare quei bambini inebetita, dall'altra parte della strada, e mentre mi chiedevo quali odori avrebbero ricordato di quei giorni, in risposta ho sentito uno di loro lamentare ad alta voce: "Pino, la smetti di scoreggiare?"
giovedì, settembre 28, 2006
CUSCINI E VAMPIRI

Non pensavo alla contessa Bathory dal marzo del 2005 quando con il Teatro della Rabbia portammo in scena uno spettacolo sulle figure di donne assassine. Erszebeth Bathory, morta all’età di 54 anni, fece rapire e uccidere giovanissime vergini per riempire la vasca da bagno del loro sangue e preservare così la sua giovane avvenenza. Dietro consiglio di maghi e fattucchiere fece torturare e uccidere oltre 650 fanciulle per legare a sé la propria bellezza e quando fu processata, il giudice Cziraky ordinò di murarla viva nel suo macabro castello in Slovacchia. Altro che Vanna Marchi e il Mago Do Nascimento.
Non ho ancora capito perché la mia mente imbastisca sogni splatter per agitare le mie notti tranquille ma forse ha qualcosa a che fare con quello che mi ha raccontato Agata ieri sera.
martedì, settembre 26, 2006
La lunga marcia verso l’idillio

Ero adolescente negli anni Ottanta quando cominciò a dilagare la piaga dell’AIDS. La sieropositività è stata l’incubo della mia generazione. E le prime informazioni crearono il panico. La mia compagna di banco temeva di essere punta da una zanzara infetta e mia madre si raccomandava che non accettassi caramelle dagli sconosciuti. Ci dissero che si attaccava col bacio, con le lacrime, con gli starnuti, con il sudore, mentre noi ripensavamo con terrore ai momenti più intimi, agli amici che avevano pianto sulla nostra spalla, alle partite a pallavolo. Poi abbiamo imparato a non parlarne più e in silenzio, ogni anno, qualcuno è stato colpito.
Ieri al telefono scopro che c’è un ragazzo, un musicista che ha dedicato una vita alla ricerca della ritmica giusta. E’ bolognese, è un amico, e una notte, imbottito di alcool, ha caricato una puttana che, come il cappio di una corda spessa, gli ha accerchiato la gola e non l’ha mollato più. Ora morirà, come sono morti tanti altri artisti, sfogando la loro ultima rabbia in quell’opera che non potranno mai terminare. E noi, che abbiamo imparato a non parlarne, presto ci dimenticheremo anche di lui.
sabato, settembre 23, 2006
Le band si sciolgono

Il lavoro con gli artisti può sembrare affascinante. Organizzare concerti, mostre e spettacoli teatrali fa pensare a qualcosa di alternativo alla routine da ufficio, ma spesso mi chiedo perché non sono entrata in banca. Mio fratello sospetta con non sia riuscita a spingere il bottone giusto per superare il filtro della sicurezza. Mia madre pensa invece che la banca sia adatta solo per quelle che amano il tailleur. Mio padre non si è mai fatto un’idea in merito. Ed eccomi qui, a lavorare con gli artisti. Dico sempre “Seppellitemi insieme all’ultimo artista, perché inutile sarebbe la mia vita senza di loro!” ma sono convinta che sarà questa loro vicinanza a seppellirmi, prima o poi. Ho accompagnato la voce, chitarra e tromba di una band bolognese, sciolta di recente, a ritirare dalla sala prove un vecchio amplificatore che stava lì dai tempi del liceo. E mentre lo guardavo caricare in macchina quella specie di cassa nera pieni di pomelli e pomellini mi sono chiesta cos’è che fa di un uomo un’artista. In risposta sono venute le parole di Jimmy Villotti pronunciate due sere fa in osteria a proposito di chitarre Fender e amplificatori Marshall: “Tu non sei un chitarrista! – ha detto con un amico - Cosa puoi saperne di un discorso con una valvola?” E ha ragione! Chi meglio di me può capirlo. Io non parlerei mai con una valvola. Semmai ci proverei con un comodino del Settecento, con la punta secca di un pennello. Spesso parlo con Word quando, senza consultarmi, sostituisce i termini con parole sue. Questo sono gli artisti: pazzi in libertà alla ricerca di nuovi interlocutori. Ed è questo il motivo per cui le band si sciolgono: per permettere ai veri artisti di parlare con le valvole.
giovedì, settembre 21, 2006
NEL LABIRINTO DEI CATTIVI

Questa mattina esco di buon'ora. Sono felice e gioconda come un bambino con le mani sporche di terra. Sotto i portici un viavai di passanti. Mi sembrano tutti sorridenti. C’è il sole e ho un appuntamento per scegliere dei quadri di Carlo Ravaioli, pittore romagnolo che ritrae immagini fantastiche di velieri sospesi a mezz’aria, piccoli borghi come labirinti di case e giovani donne. Mi ricorda Modigliani. Lui dice che “con l’ultima pennellata, il quadro muore”. Cammino ripensando a queste parole e provo un po’ di dispiacere per il distacco che vede protagonisti l’artista e la sua opera. Alla fermata del 13 c'è un cestino di rifiuti che, chissà per quale forza oscura, richiama la mia attenzione. Ne guardo il contenuto con l'interesse di un barbone. Ci sono carte di caramelle, cicche spente e giornali. Qualcuno ci ha conficcato la Repubblica di ieri arrotolata e qualcun altro una bottiglietta di acqua ancora piena. Davanti al bar ci sono due uomini che parlano di una maxi vincita incassata nel bolognese. Una ragazza indiana tiene per mano un bimbo biondo e riccioluto. Ci sono studenti, pensionati a zonzo e un uomo con la cravatta stile imperiale. Io continuo a fissare il contenuto del cestino attirata da quella stessa forza oscura che non riesco a controllare quando avverto che qualcosa lì dentro si muove. “C’è un topo!” annuncio ai compagni di fermata. In un attimo si apre una piazza deserta attorno al cestino incriminato, che spaventa anche me. Una donna grida, gli studenti ridono e l’uomo con la cravatta guarda la strada sperando vigliaccamente nell’arrivo dell’autobus. Un nonnetto si avvicina al cestino mentre tutti fanno un passo indietro come un corpo di ballo ammaestrato. L’anziano sfila la Repubblica e guarda dentro il contenitore in ferro battuto. Noi non fiatiamo in attesa del suo responso. Allunga la mano verso l’ignoto ed estrae dal cilindro magico un sacchetto trasparente con la bocca legata. Lo sgomento spintona tutte le paure. Oltre la superficie trasparente di quel sacchetto per alimenti ci sono tre creature appena nate con gli occhi ancora chiusi. Sono gatti. Mentre un brusio di fondo crescente commenta il gesto increscioso io rimango quasi inebetita e sento le lacrime fermarsi nella parte alta della gola. Un flash mi si piazza davanti agli occhi come la mano di un prete che non vuole che guardi simili sconcezze. E ricordo che ero bambina quando accadde. Giocavo seduta sui gradini di sasso della casa al mare quando vidi passare un uomo che teneva stretto un sacchetto di nylon pieno di piccoli gatti appena nati. Ho cancellato la sua faccia e ricordo solo che portava un cappello e aveva i denti marci come tanti vecchi dalle mie parti. Disse a mio padre che avrebbe cacciato i gattini in mare. Io li guardavo senza fiatare. Distinguevo tante piccole testoline glabre con gli occhi socchiusi che si muovevano lentamente. Piccole codine in un groviglio di giovani zampette che non avrebbero mai camminato. Guardai quel boia sparire verso la spiaggia e con lui se ne andò anche la mia innocenza.
mercoledì, settembre 20, 2006
Note al veleno

martedì, settembre 19, 2006
C’è rumore e rumore

Da stamattina gli operai nei locali al piano di sotto stanno trapanando senza pietà le pareti di un vecchio laboratorio che da mesi non c’è più. La vibrazione del martello pneumatico si trasmette attraverso la struttura portante del palazzo e fa tremare tutto trasferendo nelle abitazioni quella insana agitazione che solo il rumore molesto* può dare. I colpi echeggiano dalla tromba delle scale e attraversano i solai fino ad arrivare dritti dritti in casa mia come ospiti sgraditi che non accennano ad andarsene. Da quando vivo in questo palazzo ogni anno qualcuno decide di ristrutturare casa e lo fa nel modo più rumoroso possibile. Se c’è il bagno a est lo vuole a ovest, se la cucina è a nord la vuole a sud. E giù pareti per aprire gli spazi e su pareti per chiudere gli spazi aperti l’anno prima. Via pavimenti perché non più in tinta con il colore del lampadario. Via gli intonaci. Via i controsoffitti. Esco per cercare pace e la nuvola di fumo di un altro cantiere mi arriva addosso come l’alitata di un drago che ha mangiato calcinacci. Sotto i portici conto i cantieri aperti con la consapevolezza che ne è stato chiuso uno mastodontico solo da pochi mesi e che per tre anni ha creato più danni dei terremoti del Cinquecento. Sono dodici solo quelli che vedo nel tratto di strada che mi separa dall’edicola più vicina. In tutti ci sono operai che spaccano qualcosa. Penso che il rumore continuo e assordante di mazzette che colpiscono e punte d’acciaio che sgretolano mi metta di cattivo umore. Non mi permette di lavorare, mi rende irrequieta, condiziona i miei pensieri e si appropria della mia giornata che sta terminando, mentre mi accorgo di non aver concluso nulla.
* In questa città si è parlato tanto di rumore senza accordarsi sul suo significato. Il rumore molesto è come una morsa opprimente, qualcosa di sgraziato e continuativo che reca fastidio e irritazione. Mi sembra altro rispetto a un concerto in una notte d’estate!
lunedì, settembre 18, 2006
Detective per caso

Secondo episodio
Dopo la serata passata a casa di Agata ne son successe di cose! Un pomeriggio ricevo la chiamata di Vincenzo. “Sei pazza!”, mi ammonisce prima ancora di chiedere come sto. “Non puoi pubblicare certe cose sul tuo blog!” insiste. Dice che qualcuno potrebbe turbarsi per le storie che racconto, soprattutto se queste storie sono ambientate in città. Io lo tranquillizzo dicendogli che ho tantissimi altri episodi da raccontare e che può anche rassegnarsi. Si offende un po’ ma si rassegna. Poi è la volta di un amico giornalista che mi sottopone una sfilza di candidati per strapparmi il nome del peccatore, ma io mi soffermo solo sul peccato e lui ci rinuncia. Il nome lo confesso solo a un’amica che vive dall’altra parte della città. E’ persona discreta e curiosa e ha trovato un ottimo argomento per scucirmi i dettagli. Chiamo Agata e me ne vado da lei con il binocolo. Sono le sei di pomeriggio. Parliamo del terzo desiderio, della festa a casa del vicino e poi dal lucernaio del suo studio mi affaccio per sbirciare. A fine estate, sui colli di Bologna, la vegetazione sembra difendersi ancora dalla speculazione edilizia. Macchie di verde più intenso si possono notare nelle zone meno assolate e con un po’ di fortuna si può vedere qualche volpe. Agata mi racconta che una mattina ha visto transitare una famiglia di cinghiali. Sembravano in vacanza. La tentazione di spiare il vicino è forte sia per me che per il mio binocolo che si posiziona sulla sua villa e ne mette a fuoco i contorni. La finestra dello studio dove qualche sera prima è andato in scena un inedito spettacolo è coperta da una tenda che non lascia trasparire nemmeno le ombre. Forse ha letto il blog? In giardino c’è un uomo di colore che lavora. Come ogni snob che si rispetti anche il nostro impiegato con la villa sui colli ama dare ordini a quelli con la pelle scura. Nel cortile di sampietrini ci sono un’auto di lusso e una vecchia Citroen beige impolverata. Indovinate un po’ quale delle due è la sua! “Serata fiacca” mi lamento. “Perché non ci avviciniamo dal sentiero dei cinghiali?” propongo. Convinco Agata e ci incamminiamo. Ai piedi mi trovo un paio di sandali dorati, sono di D&G (un regalo!). La calzatura più costosa di tutto il mio guardaroba, non propriamente adatta per una scampagnata. La natura ci mostra subito un intreccio di insidiose propaggini che ci fanno capire di non essere le benvenute da quelle parti. “Ah c’è una biscia!” urlo. La biscia non c’è e Agata ride. Una come lei non teme nemmeno le tarantole. Un giorno l’ho vista raccogliere da terra una mantide religiosa. In più ha i piedi coperti. Io mi sento come in bikini dentro a una chiesa durante la festa del Patrono. Striscio il braccio contro un rovo e mi ferisco appena, ma un leggero segno rosso compare immediatamente e sento bruciore. Il tramonto si è portato via il sole dietro la collina e il buio che incombe mi mette agitazione. Non sono tagliata per l’avventura, penso. Agata è davanti a me e cammina sicura. Io sono preoccupata per le mie scarpe. A ogni passo le vedo sempre peggio. I tacchi si conficcano nella melma del terreno vischioso per le piogge degli ultimi giorni. C’è un piccolo boschetto da attraversare e vorrei tornare indietro. Agata si inoltra in quell’oscurità. Guardo attraverso il binocolo. Le cortecce umide degli alberi sembrano enormi e non lasciano passare lo sguardo. Dietro la lente pare una foresta secolare. “Cazzo c’è un uomo!!!” urlo strozzata. Agata lo vede, è lontano da noi ma vicino alla villa. Sembra un meccanico con la barba. “Scappiamo!” dice. Lei che non teme nemmeno le mantidi religiose dice scappiamo? La paura si concentra nella parte più alta della schiena e mi spinge a correre. Agata mi alita sul collo e mi incita alla fuga. Io corro fra le pareti informi della boscaglia, torno sul sentiero dei cinghiali mentre i miei piedi affondano nel terreno e spezzano i piccoli rametti che ostruiscono il passaggio. Corriamo come pazze ansimando il nostro spavento. Penso che quell’uomo ci sta inseguendo, magari porta con sé un’accetta da insanguinare o tenta di infilzarci con una balestra da precisione. Io corro senza mai voltarmi indietro e non so più se dietro di me c’è ancora Agata o mi sta raggiungendo l’uomo con la barba, la lama della sua accetta o la punta della freccia della sua balestra. Il cancello di casa è aperto. Entriamo spedite. Lei ha in mano le chiavi del portone. Apre. Ci infiliamo in casa e serriamo la porta con il catenaccio. Lei si siede su un gradino. Riprendiamo fiato fissandoci negli occhi. Poi comincia a ridere mentre guardiamo i miei sandali distrutti.
venerdì, settembre 15, 2006
Senzatetto e Senzaocchi

Il primo clochard che incontrai a Bologna era vestito di nero. Lo chiamavano “Cristo” e aveva lunghi capelli unti, la fronte alta e stempiata, i pantaloni a zampa e una barba asimmetrica che gli copriva il collo increspato e arrossato dal vino e dal sudore. “Pèntiti, donna di poca fede!”, mi disse. Era scalzo e tracannava acqua fresca da quella fontana che ora non c’è più, come un terreno arido. I piedi insudiciati dai marciapiedi della città e le unghie lunghe e spesse. Guardai sbalordita. Non avevo mai visto un uomo ridotto in quel modo. Lui mi venne incontro. “Pèntiti! Pèntiti! Pèntiti!” ripeté con il ritmo di un’ascia che taglia un tronco. “Pèntiti, donna di poca fede!”, e io mi pentii di non aver scelto un’altra strada per raggiungere il centro. Il secondo clochard lo vidi di notte. Dormiva in una delle nicchie sotto il portico di San Giacomo Maggiore, le stesse che ora sono state chiuse con enormi pannelli di legno oltre i quali possono riposare solo fantasmi murati. Era rosso di capelli, sembrava uno straniero, forse irlandese. Non aveva coperte, né guanciali e teneva in mano una cipolla mangiucchiata. Era freddo e provai misericordia per la sua notte gelata e ripugnanza per il suo cibo lasciato a metà. Ne vidi tre nel sottopassaggio della stazione avvolti in una nuvola acre di piscio e madore. Erano sdraiati a terra. Uno fumava, uno si grattava la testa e uno sputava l’ultima sorsata di birra calda. I viaggiatori con gli sguardi delatori affrettavano i loro passi verso quei binari che li avrebbero portati altrove, mentre io non volevo respirare quel fetore e mi coprivo con le mani la bocca. Poi ne ho visti altri senza mai guardarli. Illusioni ottiche che vagano nella nebbia. Finché una sera, vicino ai cassonetti della spazzatura, ce n’erano due che facevano l’amore. Uno sull’altra, dentro una grande scatola di cartone che lasciava fuori solo quattro piedi neri, mugolavano di piacere a un passo da un convento. Non avevo mai pensato prima che due vagabondi potessero accoppiarsi in quel modo. Come gatti sotto una buona luna o come uomini primitivi sul fondo di una caverna. Credevo che il rito della seduzione si costruisse sulla bellezza, sui profumi, sul desiderio del corpo altrui. E credevo che i senzatetto non avessero un sesso. Ma capii che a forza di ignorarli, di loro non avrei mai saputo nulla.
Un anno fa se ne andava il mio prozio, clochard per non aver sopportato la morte della moglie. Dormiva in un rudere a cielo aperto con una trentina di gatti e una turba di piccioni. Non ha mai voluto tornare, e io credo di sapere il perché.
(“Senza tetto irlandese” foto la Repubblica)
mercoledì, settembre 13, 2006
Che bella gente!

Spesso mi chiedo che fine abbia fatto la Bologna del Cinquecento. Il rinascimento è transitato su questa città senza lasciare nulla? Coltivando il dubbio, quale miglior compagno di viaggio, amo spulciare nelle vecchie cronache cittadine per avere il senso della provenienza e ricostruire le radici. E “spulciando” ho scoperto che in centro viveva una donna straordinaria. Si chiamava Ginevra Sforza ed era la signora di Bologna. Ginevra, figlia di Alessandro, signore di Pesaro, sposò in prime nozze Sante Bentivoglio all’età di 12 anni. Lui era già un uomo maturo, sulla trentina e rosso di capelli. Teneva saldamente la città assieme alle altre famiglie e al legato pontificio e amava una certa Nicolosa Sanuti, moglie del conte. Ginevra, giovane e inesperta, cominciò la sua vita bolognese con l’entusiasmo di un sequestrato. I matrimoni combinati erano un fatto del tutto naturale per chi li organizzava, ma la giovane vittima si ritrovava ancora bambina, sposata a un estraneo e costretta a rapporti intimi con un uomo che la possedeva solo per puro piacere e per assicurare la discendenza. Ginevra, nella solitudine del suo ruolo di moglie lasciata a palazzo si innamorò di Giovanni, il quindicenne figlio di Annibale, cugino di Sante. Le cronache non riportano dell’idillio sbocciato fra i due ma io spesso li ho sognati, nascosti nel loggiato, dietro le fontane di pietra, sotto le grandi scalinate di quella nobile dimora che venne distrutta dai bolognesi nel maggio del 1507. Sì, perché i bolognesi anche questo fecero. Fomentati dal papa, abile manovratore di ogni realtà (e poi ditemi che Bologna non è papalina!) il popolo felsineo distrusse a pietrate il palazzo Bentivoglio. Considerata dagli storici del tempo la più bella costruzione che ci fosse in Italia (il rosso del mattone sposato al grigio della pietra di Porretta al color oro delle decorazioni sulla facciata), la dimora di Ginevra e Giovanni Bentivoglio (i due, dopo la “strana” morte di Sante si sposarono e allevarono 16 figli) venne abbattuta a pietrate e quel che ne rimane oggi è un isolato informe, in pieno centro storico, con edifici multistile in netto contrasto con ciò che li circonda. Una porzione di città dove non regna mai la pace. Si tratta dell’isolato antistante Piazza Verdi. Il palazzo distrutto era situato in quella porzione di terreno delimitata da via Zamboni, via Belle Arti, via Castagnoli e via del Guasto. La pendenza dei giardini del Guasto altro non è che un ammasso di detriti, cocci e legni spaccati del palazzo più bello d’Italia. Il Teatro Comunale altro non è che una scelta di cattivo gusto (pensare di fare spettacoli sopra i cadaveri che rimasero imprigionati dal crollo dell’edificio mi sembra un po’ troppo!). La nuova costruzione, qualcosa che nulla a che fare con un centro storico, altro non è che l’ennesima speculazione edilizia all’italiana (non oso pensare quel che è stato trovato durante gli scavi!). E quel che accade in Piazza Verdi è la naturale conseguenza secondo l’antica arte orientale del Feng Shui. Ginevra morì di crepacuore, esiliata a Parma per volere di Giulio II, entrato in città da re, acclamato dalla folla. E venne sotterrata assieme al ricordo del suo bel palazzo. Anche questi sono i bolognesi.
martedì, settembre 12, 2006
Confidenze alla nicotina
Quando penso a quel che hanno fatto alla signora della porta accanto mi viene ancora voglia di accendere una sigaretta anche se non fumo più da cinque anni. Un tempo l’accendevo in compagnia, in attesa dell’autobus, prima e dopo gli esami. C’era l’ultima paglia prima di andare a dormire. C’era la paglia scroccata, e quella lasciata a metà. Mi godevo quella dopo il caffè, quella dopo una litigata, quella durante il “dopo”. Il primo pacchetto di sigarette (Philippe Morris gialle da venti) lo comprai a 17 anni e lo fumai nel tempo di una giornata perché mia madre non lo trovasse nelle tasche del giubbotto. Fumavo nei bagni della scuola con un compagno di banco che fino all’anno prima era stato un fervido sostenitore della causa dei non fumatori. Un’estate passai alle Chesterfield perché, si diceva, fossero le sigarette di Elvis Presley. Io e Melissa, un’amica di Bergamo, ci spostavamo dalla riva in canotto per fumarle lontano da occhi indiscreti. Un giorno un’onda ci bagnò il pacchetto e noi le fumammo tutte senza filtro. Frequentando compagnie di maschietti venni iniziata alle Luky Strike, le sigarette da duri. Le fumavo dentro una giacca di pelle che serviva per mitigare il mio aspetto da brava ragazza. Il passaggio alle Marlboro fu quasi naturale. Prima le rosse, più forti, poi quelle del pacchetto oro. Con i miei primi sandali col tacco alto mi coinvolse la moda delle sigarette leggere e lunghissime, quella da diva, mi diceva sempre un amico gay. E via con le Multifilter azzurre pacchetto morbido, le stesse di Gloria Guida. Per anni ho coinvolto tutti nel mio vizio. Il postino di via del Cestello me le portava assieme alla posta. Ho fumato in macchina, il moto, in bicicletta. Ho fumato sul ponte di una nave che raggiungeva la costa danese. Ho fumato in riva al fiume, ai tavolini di un bar mentre giocavo a carte. Ho fumato sulla gradinata di una chiesa quando si è sposato un mio vecchio amore. E un giorno ho detto BASTA e con le sigarette in tasca ho perso l’abitudine. Ho detto basta come si dice basta a qualsiasi altra cosa. Ci si stanca di tutto, io mi stancai di fumare. Ma non sono mai stata un’ex fumatrice. Non ho mai fumato la mia ultima sigaretta. Rimango una fumatrice che non pratica più. Ed è per questo che quando penso a quel che hanno fatto alla signora della porta accanto mi viene ancora voglia di accenderne una.
lunedì, settembre 11, 2006
Il più bel tacer non fu mai scritto!
So che fuori è l’11 settembre, ma le mie vicine cantano che serà serà di Doris Day e non voglio ricordare. Non voglio vedere servizi al telegiornale, dibattiti, talk show. Non voglio. Mio nonno diceva sempre che la natura non poteva distruggere più dell’uomo. Aveva visto alluvioni, terremoti e guerre, e sapeva di cosa stava parlando.
domenica, settembre 10, 2006
BOLOGNA – CERVIA in una dormita

venerdì, settembre 08, 2006
DETECTIVE PER CASO

Ho meditato a lungo sull’opportunità di una simile confidenza e giungo a conclusione che conviene raccontare: occhio che vede è un cuore che duole, ma anche un cervello che pensa.
Ieri in tarda serata ricevo un messaggio di Agata, un’amica che vive sui colli. La raggiungo portando con me un vecchio binocolo appartenuto a mio nonno. Lui ci guardava i gabbiani, io ci spio la città quando salgo sopra il livello del mare. Agata è un architetto che ama la solitudine e ha sposato un uomo che non c’è mai. Dopo una lunga chiacchierata sui perché e i percome della vita mi affaccio dal piccolo lucernaio del suo studio e all’istante compare una distesa di luci che risalta sullo sfondo scuro di una Bologna notturna. Sembra lo schermo di un flipper. Una visione che ipnotizza. Distinguo le vie, qualche edificio, e vedo troneggiare le due torri. Avvicino lo sguardo bramoso alle lenti del binocolo e comincio a spulciare il circondario. Ville, villette e villettine si perdono fra le macchie di una vegetazione padana. Un piccolo boschetto, una lunga siepe e un viale di cipressi che porta dritto dritto a un vecchio casolare in ristrutturazione. Vicino si estende la proprietà di un uomo da anni ben inserito nel tessuto sociale cittadino e impiegato comunale che ha ricoperto diversi ruoli di prestigio al fianco dei politici più noti del panorama bolognese e non. C‘è una festa. Nel cortile, sopra un’ordinata pavimentazione in sampietrini, quelli che negli ultimi anni stanno togliendo dalle strade antiche della città (non mi meraviglierei se fossero gli stessi!) spiccano automobili di grossa cilindrata con le carrozzerie spolverate a dovere. Gli ospiti sono in giardino e qualcuno sosta col bicchiere in mano su di una terrazza. Io e Agata smorziamo la luce: certi giochi si fanno solo la buio. Fra la gente, riconosco un paio di politici importanti, un noto industriale del modenese, una commerciante di antiquariato e un cantantucolo impegnato a intrattenere i presenti. La villa è davvero lussuosa. Oggetti d’arte, un mobilio impegnativo, la piscina, statue e fontane in pietra, piante finemente potate. Mi chiedo come possa, un impiegato comunale, raggiungere un tale livello di ricchezza con il solo stipendio regolare, ma in realtà preferisco non saperlo. C’è anche un noto esponente del mondo cattolico cittadino e questo non mi meraviglia dati gli orientamenti politici dell’ospite (a destra e a sinistra quando fa comodo ma sempre attaccato alla veste di qualche prelato importante). Dalla mia posizione vedo tutto il lato nord della casa. Agata si siede ai miei piedi e io le passo la cronaca. A tratti giunge anche il chiacchiericcio e qualche risata sonora. Si beve in piscina! Una specie di maggiordomo si aggira distratto con un vassoio luccicante e un altro versa bicchieri di vino bianco che sgorga da una bottiglia scura con etichetta color arancio. Si accende una luce al primo piano. Io seguo con il binocolo il bagliore e metto a fuoco. Da quella angolazione vedo una porzione di stanza. E’ uno studio. Mobili scuri e tanti quadri alle pareti. Di schiena alla finestra c’è un uomo vestito di scuro. Capelli bianchi disordinati e un telefonino in mano. Digita qualcosa, forse un messaggio. Si gira verso la finestra e io d’istinto mi ritraggo. Poi riprendo a guardare. E’ lui: il “padrone di casa”. L’impiegato comunale con la villa sui colli. Lo riconosco. L’ho visto qualche volta sul giornale. L’ho visto nelle occasioni pubbliche. Dopo qualche istante compare sulla soglia un giovane in jeans e camicia bianca. E’ moro, abbronzato, con in mano un calice. Il nostro uomo si avvicina al ragazzo, quasi lo investe, gli si butta addosso e comincia a baciarlo con foga. Lo spettina, gli tocca il culo. In giardino gli invitati sorridono e qualcuno, compresa la giovane fidanzata e l’amico prelato, si chiederà dove sia il loro ospite. I due, eclissati da una tenda, si scambiano favori sessuali mentre io, giuro, non guardo. Passo il binocolo ad Agata. Lei ride di gusto. “Hai capito il chierichetto!” esclama. “Eppure sembrava così un timorato di Dio!”
giovedì, settembre 07, 2006
A Bologna non c’è il mare!
Sembrerebbe una mattina come le altre. Qualcuno nel palazzo di fianco sta suonando il piano e le sue note si impigliano nel sottofondo informe del traffico mattutino. Dalla finestra entra il pianto di un bambino, una radio trasmette l’intervista di un esperto in economia e sento la voce della mia vicina che è tornata dal festival di Venezia. Parla piano e racconta di divi e divine. Il passo sostenuto dei passanti riecheggia sotto il portico e i motorini sfrecciano in entrambe le direzioni nonostante il divieto. Negli anni Ottanta vivevo in riviera e settembre era il mese della meraviglia e dell’attesa. Dalla finestra entrava il pianto di un bambino, la radio trasmetteva interviste a De Gregori e ai fratelli Righeira, i vicini urlavano da una parte all’altra della strada la fine di un’estate lavorativa e gli ultimi turisti camminavano lentamente verso est. Io, un po’ secchiona e un po’ romantica sistemavo i nuovi quaderni, penne e gomme profumate, nel solito astuccio con gli amanti di Kim nudi (ricordate la serie L’amore è?) e ripensavo a quei sorrisi conosciuti sulla spiaggia e spariti lungo la scia di un’autostrada intasata. Oggi sistemo blocnotes e detesto le gomme profumate. Non ho più il mio astuccio con gli amanti nudi e non ricordo quei sorrisi conosciuti sulla spiaggia, ma camminerei felice verso est, come l’ultimo dei turisti, se fossi sicura di trovarci il mare. Ma da qui verso est troverei solo le due torri, un portico con i tavolini all’aperto e più giù la piazza.
martedì, settembre 05, 2006
Sculture e scooture
Mi sbarazzerò del mio vecchio scooter, ho deciso! Ma non prima di aver raccontato la sua storia:
era il 1996 quando per un colpo di “fortuna” mio padre si trovò per le mani una cartella vincente del famoso Bingo, il concorso studiato dall’ufficio marketing del Carlino per fidelizzare i lettori. Complimenti, aveva vinto uno scooter Gilera! Il vantaggio fu solo mio, perché dopo qualche giorno un corriere gentile me lo consegnò a Bologna. Il nome Typhon spiccava nuovo e luccicante sulle fiancate blu e rosse. Non avrei mai comprato un oggetto del genere ma come si dice “a caval donato…”. E in bocca non guardai. Anzi, così motorizzata, cominciai ad assaporare un’indipendenza che non avevo mai avuto prima. Potevo scappare sui colli, raggiungere ogni parte della città, caricare le borse del supermercato e cercare un po’ d’aria nei caldi pomeriggi d’estate. Con il mio typhon ho preso la pioggia d’autunno e l’acquazzone di primavera. Ho preso anche qualche buca che mi ha frantumato il parabrezza e una multa per divieto di sosta. Sono caduta sulla neve, ho rischiato di investire la fiancata di un auto che non aveva rispettato uno stop, ho caricato gli amici e “coperto” l’intera città presenziando alle prime conferenze. Con lui ho raggiunto gli uffici universitari e ritirato la pergamena della laurea, ho accompagnato in stazione un caro amico che partiva e vagato per la città fiduciosa verso i primi colloqui di lavoro. Poi ha deciso di lasciarmi…a piedi. La prima volta passò quasi inosservata. Sarà la candela bagnata, il carburatore sporco, l’aspiratore della benzina intasato. Ma non era nulla di tutto questo. Il meccanico non ha trovato soluzioni durature e io sono rimasta a piedi altre volte, fino a oggi quando ho preso la sofferta decisione: lo porto da Simone Bellotti!
lunedì, settembre 04, 2006
Chi è cresciuto metta il dito qui sotto!
Diventare adulti non piace, lo so. E’ come confessare di avere accettato una condizione di irreversibilità che con la complicità del tempo porta inevitabilmente alla vecchiaia. Ma in fondo cosa sono i “vecchi” se non giovani trattenuti da corpi increspati che hanno perduto la freschezza?
Mio nonno morì a ottant’anni e c’è chi giura che non era ancora invecchiato. Usciva in moto e vagava per la campagna romagnola. Sostava nell’aia delle case dei contadini, mangiava le pesche staccate dall’albero e ripartiva. A volte raggiungeva le Valli di Comacchio per guardarsi i gabbiani col binocolo. Raccoglieva gli uccellini feriti per strada e scherzava sulla sua vedovanza burlandosi dei grassi, dei politici e del clero esorcizzando la morte fra battute in dialetto e un pizzico di nostalgia per la sua bellezza sfiorita. Se n’è andato di sera, mentre riposava seduto in poltrona. Odiava le mosche e rideva quando mi vedeva ballare. Toccava il culo a mia nonna e diceva sempre “E’ per questo che ti voglio tanto bene!” Settembre era il suo mese preferito.
domenica, settembre 03, 2006
UNA CASA IN STILE FENG SHUI
Dal giorno del trasloco sapevo che sarebbe cambiata la mia vita, ma non immaginavo di farmi prendere la mano in questo modo. Dopo aver letto tutto sulla bioarchitettura, sono impazzita per le arti orientali e arredo casa seguendo il metodo del Feng Shui. Attraverso lo studio del chi e della stella polare (chi non sa cos’è può sempre chiedermelo), l’antica arte cinese insegna come posizionare il proprio letto in base alla data di nascita, dove sistemare mobili e piante ornamentali, come illuminare gli ambienti e quali colori usare per le pareti. In casa c’è l’angolo della fortuna, quello della carriera, quello della famiglia e così via. Da me, per esempio, nell’angolo dei familiari c’è il water e questo la dice lunga sui rapporti che intrattengo con certe persone, e nel punto della ricchezza c’è il frigorifero che sta ad indicare che con il mio conto in banca si potrebbero congelare i cibi. Otto punti in ogni stanza e in tutto il perimetro abitato. Otto punti da individuare e da curare per favorire relazioni e abbondanza. E’ un po’ come la danza della pioggia per i contadini, un rito propiziatorio, un’espressione scaramantica. Il metodo, tutto sommato è semplice, ma se decidete di darvi al Feng Shui non confessatelo agli amici. I miei si introducono in casa chiedendo: “posso camminare su questo pavimento? Con quale piede devo entrare?” e altri quando mi chiamano mi dicono: “vai nell’angolo della disperazione che ti devo dare una brutta notizia!”
sabato, settembre 02, 2006
SILENZIO! E’ TORNATO L’URLO!

Alla notizia dell’urlo rubato ho urlato anch’io. Era il 22 agosto del 2004 quando al telegiornale un elegante giornalista sconosciuto, che sostituiva i volti più noti, fuori città per la vacanza, comunicò, con la freddezza di chi è preoccupato solo a pronunciare bène ogni parola con l’accènto corrètto, che l’Urlo e la Madonna di Munch erano stati rubati dal museo di Oslo in circostanze poco chiare. Come? Sono stati rubati? Com’è possibile che qualcuno riesca a sottrarre due quadri da un museo in pieno giorno? E me lo dice un giornalista in quel modo? La polizia di Oslo non ha mollato l’osso e in due anni di ricerche e arresti vari, ieri ha riportato a casa i due sequestrati. Ora speriamo solo, in silenzio, che siano gli originali.

 Lo potete trovare da:
Lo potete trovare da:
